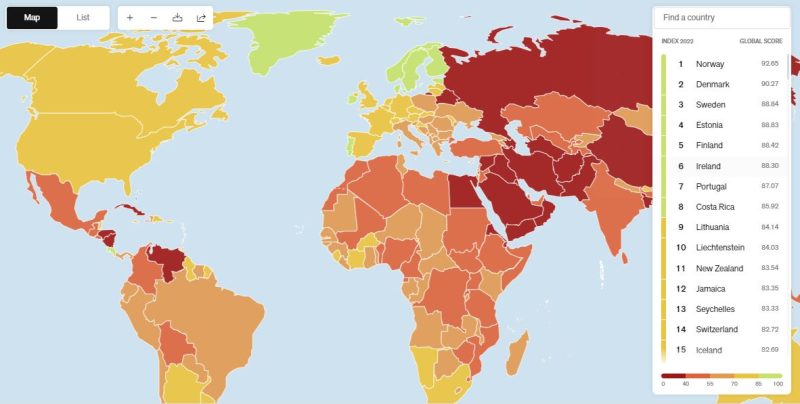Che piaccia o meno, la carta mondiale dei rapporti di forza economici è stata ridefinita negli ultimi cinque anni. La crisi ha accelerato un processo già attivo: Brasile, Cina, India sono solo alcune delle economie che hanno catturato la ribalta mondiale. Centrando l’attenzione sull’area asiatica, si è arrivato a definire un neologismo per indicare un’area unica: la Cindia (Cina + India, aut. Federico Rampini). Difatti, i ritmi espansionistici di questi Stati-continenti hanno visto performance straordinarie. Sarebbe ingeneroso infierire in un confronto che metta di fianco l’economia italiana, ad esempio, con quella della Cindia: ne usciremmo con le ossa rotte. Verrà anche obiettato che, è vero, il livello di crescita è stato a lungo in doppia cifra – mentre il Belpaese guadagnava a stento lo zero virgola – però esistono condizioni lavorative e diseguaglianze sociali che disegnano un quadro raccapricciante. Si guardi però, per un istante, agli investimenti nel campo della ricerca e dell’istruzione. Mentre in Italia si mandano i ricercatori all’estero, oppure gli si offrono contratti vergognosi; mentre si smantella l’istruzione pubblica azzerando ogni investimento in qualità e formazione, in India si è garantito l’ampliamento della formazione scolastica a 192 milioni di bambini e si sono tenuti aggiornati gli insegnanti perché potessero garantire un’istruzione adeguata. Si sono gettate le basi per superare le economie tradizionalmente dominanti. Quali sono i risultati sul piano economico? Lo hanno spiegato in immagini Le Iene: giovani laureati o studenti indiani che part-time (e un part-time è inteso come un turno di lavoro di 8 ore…), gestiscono il call center per aziende di tutto il mondo: anche italiane. Fa specie verificare come un giovane indiano parli correntemente 3 lingue – ed erano migliaia a lavorare in una sorta di distretto industriale del call center in outsourcing – mentre un neodiplomato italiano, mediamente, ha una conoscenza dell’inglese quantomeno approssimativa. È una triste realtà, ma è un dato del quale prenderne atto. Se l’India è un caso scuola di quanto accaduto nei paesi del BRIC, ovvero, il cartello di quelle che, entro il 2050, saranno le guide dell’economia mondiale (Brasile, Russia, India, Cina), altrettanto non può dirsi sotto il piano sociale e dei diritti. Tra i primatisti (in negativo), la Cina. Ci sarebbe da analizzare anche il caso Russia, tutt’altro che un esempio di Paese libero, però, quanto accaduto nell’ultima settimana merita l’ennesimo focus su Pechino. È la gestione del libero dissenso a caratterizzare la politica cinese: non è permesso. Così, abbiamo assistito a Hu Jintao – presidente della Repubblica Popolare Cinese – venire in Italia a siglare accordi commerciali (sui quali ci sarebbe da chiedersi per chi sia il reale vantaggio) come si addice al migliore dei liberali; salvo, poi, minacciare uno stato sovrano, la Norvegia – del tutto estranea all’assegnazione dei premi nobel, se non per la sede in cui si consegnano – per aver consegnato il premio per la pace a Liu Xiaobo, dissidente cinese condannato a 11 anni di reclusione in febbraio.
Che piaccia o meno, la carta mondiale dei rapporti di forza economici è stata ridefinita negli ultimi cinque anni. La crisi ha accelerato un processo già attivo: Brasile, Cina, India sono solo alcune delle economie che hanno catturato la ribalta mondiale. Centrando l’attenzione sull’area asiatica, si è arrivato a definire un neologismo per indicare un’area unica: la Cindia (Cina + India, aut. Federico Rampini). Difatti, i ritmi espansionistici di questi Stati-continenti hanno visto performance straordinarie. Sarebbe ingeneroso infierire in un confronto che metta di fianco l’economia italiana, ad esempio, con quella della Cindia: ne usciremmo con le ossa rotte. Verrà anche obiettato che, è vero, il livello di crescita è stato a lungo in doppia cifra – mentre il Belpaese guadagnava a stento lo zero virgola – però esistono condizioni lavorative e diseguaglianze sociali che disegnano un quadro raccapricciante. Si guardi però, per un istante, agli investimenti nel campo della ricerca e dell’istruzione. Mentre in Italia si mandano i ricercatori all’estero, oppure gli si offrono contratti vergognosi; mentre si smantella l’istruzione pubblica azzerando ogni investimento in qualità e formazione, in India si è garantito l’ampliamento della formazione scolastica a 192 milioni di bambini e si sono tenuti aggiornati gli insegnanti perché potessero garantire un’istruzione adeguata. Si sono gettate le basi per superare le economie tradizionalmente dominanti. Quali sono i risultati sul piano economico? Lo hanno spiegato in immagini Le Iene: giovani laureati o studenti indiani che part-time (e un part-time è inteso come un turno di lavoro di 8 ore…), gestiscono il call center per aziende di tutto il mondo: anche italiane. Fa specie verificare come un giovane indiano parli correntemente 3 lingue – ed erano migliaia a lavorare in una sorta di distretto industriale del call center in outsourcing – mentre un neodiplomato italiano, mediamente, ha una conoscenza dell’inglese quantomeno approssimativa. È una triste realtà, ma è un dato del quale prenderne atto. Se l’India è un caso scuola di quanto accaduto nei paesi del BRIC, ovvero, il cartello di quelle che, entro il 2050, saranno le guide dell’economia mondiale (Brasile, Russia, India, Cina), altrettanto non può dirsi sotto il piano sociale e dei diritti. Tra i primatisti (in negativo), la Cina. Ci sarebbe da analizzare anche il caso Russia, tutt’altro che un esempio di Paese libero, però, quanto accaduto nell’ultima settimana merita l’ennesimo focus su Pechino. È la gestione del libero dissenso a caratterizzare la politica cinese: non è permesso. Così, abbiamo assistito a Hu Jintao – presidente della Repubblica Popolare Cinese – venire in Italia a siglare accordi commerciali (sui quali ci sarebbe da chiedersi per chi sia il reale vantaggio) come si addice al migliore dei liberali; salvo, poi, minacciare uno stato sovrano, la Norvegia – del tutto estranea all’assegnazione dei premi nobel, se non per la sede in cui si consegnano – per aver consegnato il premio per la pace a Liu Xiaobo, dissidente cinese condannato a 11 anni di reclusione in febbraio.  Rispetto a dieci anni fa, però, limitare la propagazione delle notizie è cosa assai ardua. La Rete ha collegato globalmente gli avvenimenti che riguardano sei miliardi di persone, Pechino può limitare l’informazione entro i propri confini impedendo che circoli anche un solo riquadro sul nobel – prima volta nella storia – a un cinese. È proprio questa gestione della comunicazione ad auto preservare il potere dei dirigenti cinesi: fino a quando non ci sarà libertà di espressione e di pensiero, Pechino potrà certamente bearsi di essere traino economico mondiale per il 2011 (+9.6% previsto, in calo rispetto al +10.5% del 2010) ma andrà verso un inevitabile rischio di rivolta interna: fino a che punto, due miliardi di cinesi resteranno passivi davanti a questo status quo?
Rispetto a dieci anni fa, però, limitare la propagazione delle notizie è cosa assai ardua. La Rete ha collegato globalmente gli avvenimenti che riguardano sei miliardi di persone, Pechino può limitare l’informazione entro i propri confini impedendo che circoli anche un solo riquadro sul nobel – prima volta nella storia – a un cinese. È proprio questa gestione della comunicazione ad auto preservare il potere dei dirigenti cinesi: fino a quando non ci sarà libertà di espressione e di pensiero, Pechino potrà certamente bearsi di essere traino economico mondiale per il 2011 (+9.6% previsto, in calo rispetto al +10.5% del 2010) ma andrà verso un inevitabile rischio di rivolta interna: fino a che punto, due miliardi di cinesi resteranno passivi davanti a questo status quo?
Fabiano Polimeni