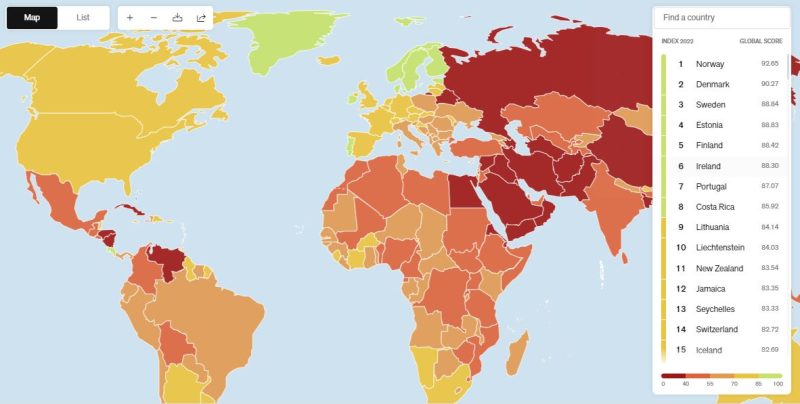Riceviamo e Pubblichiamo
Riceviamo e Pubblichiamo
Sempre più pressanti e preoccupanti sono rappresentate soprattutto dal mondo forense le esigenze della “ridefinizione di una deontologia giudiziaria” idonea a rilegittimare i giudici come garantiti autentici della divisione dei poteri e dei diritti fondamentali dei cittadini. Ma la ridefinizione di una deontologia presuppone il riferimento ad un modello di magistrato da privilegiare. Ed è a questo punto che il problema mostra tutta la complessità. Come è noto, specie tra i magistrati più impegnati nel contrasto della criminalità mafiosa – e, più in generale, delle diverse forme di criminalità del potere – è andata, nel corso degli anni, sempre più affermandosi la consapevolezza che per fare bene il proprio mestiere il giudice non può rinchiudersi in un guscio isolato ed illudersi di essere un semplice applicatore di norme e di concetti giuridici astratti: egli deve piuttosto rivolgere lo sguardo al mondo reale, rendersi conto dei nessi tra la criminalità e le diverse forme di potere nonché dei limiti e degli ostacoli cui va incontro l’esercizio della giurisdizione penale anche per effetto dei condizionamenti politici, per aprirsi alla società esterna per comprendere i fenomeni sociali e farsi interprete delle istanze di giustizia che provengono dai cittadini. Questa nuova apertura del magistrato agli universi esterni ha segnato un indubbio progresso, innanzitutto in termini di cultura di ruolo. Ma, come sempre, la medaglia ha un rovescio. L’esigenza di non rinchiudersi in una torre di avorio ha, infatti, finito con il promuovere via via forme di presenza e impegno verosimilmente sproporzionate per eccesso. In particolare, tra i più consapevoli magistrati antimafia è maturata la convinzione che allo scopo di contrastare fenomeni complessi come le mafie sia necessario che gli stessi magistrati si facciano carico di funzioni pedagogiche, generalizzate declamazioni volte ad informare e orientare l’opinione pubblica nelle scuole, nei luoghi di lavoro, nelle associazioni di volontariato, nelle famiglie. Di certo sono molti coloro che condividono la necessità di questo ruolo pedagogico non sino al punto di avallarne un’interpretazione così estremistica da trasformare il magistrato antimafia in una sorta di nuovo “tribuno del popolo”. Non per questo vengono tuttavia meno le ragioni di possibile preoccupazione: in realtà è sempre incombente il rischio che l’attività pedagogica del magistrato, pur se svolta a fin di bene, ne accentui le valenze politiche nei termini di un pernicioso populismo giudiziario. La specificità del ruolo del magistrato antimafia può, per altro verso, manifestarsi in una dimensione che attiene più direttamente all’esercizio dell’attività professionale in senso stretto e che finisce con l’avere a che fare con il grosso problema degli scopi dello stesso processo penale. Sotto questa angolazione prospettica assurge ormai al rango di verità accettata che, per prevenire e reprimere adeguatamente i fenomeni di criminalità mafiosa, pubblici ministeri e giudici devono dotarsi di una cultura professionale che ben trascende la sfera del diritto: la conoscenza della storia, della sociologia, della criminologia, dell’economia e di altre discipline extragiuridiche, funge da presupposto necessario per delineare l’orizzonte di senso, senza il quale non sarebbe possibile pervenire alla stessa comprensione giudiziaria dei fenomeni.
Ma, la medaglia, ha un rovescio, perché il rischio che la giustizia penale si tramuti in una sorta di sociologia del crimine nella sede sbagliata è sempre incombente. Ed è tale perché i fatti di mafia se collegati con vicende storico-politiche complesse ed oscure, sono così ambigui e di così ardua decifrazione da mettere fortemente alla prova i principi garantistici del processo penale. Sicché, la sacrosanta ricerca della verità fattuale rischia di incamminarsi per scorciatoie che assumono impropriamente il saper storico-sociologico (o persino le “pre-comprensioni” soggettive!) a fonte di verità inoppugnabili, così trascurandosi che la stessa storia e la stessa sociologia (e più ancora le intuizioni personali!) sono ben lungi dal fornire conoscenze sicure ed univoche. In ogni caso, la tentazione di ridurre il processo a strumento di conferma di presunte verità di altra matrice può comportare una arroganza intellettuale che disdegna il confronto con l’immane concretezza della realtà, con la contraddittorietà e la frammentarietà dei fatti, con la frequente casualità degli accadimenti e la loro irriducibile resistenza a trovare spiegazioni in grande regie o disegni predeterminati. Al contrario una nuova auspicabile deontologia giudiziaria non può non recuperare il valore irrinunciabile del dubbio cognitivo, quale riflesso della consapevolezza epistemologica del carattere probalistico e induttivo della verità processuale.
A questo punto, torna in realtà a riproporsi l’interrogativo, più che sugli scopi in generale del processo penale, sugli scopi di un processo incentrato su vicende di mafia a loro volta strettamente intrecciate con tragici accadimenti di rilevanza storico-politica. E la domanda diventa questa: un tale processo mantiene pur sempre quale principale funzione quella di accertare fatti in vista del loro inquadramento in precisi quadri delittuosi? Oppure, un tale processo può ben esaurire la sua funzione utile nel contribuire a fare maggiore chiarezza sulla verità storica in sé considerata, a prescindere dalla rilevanza giuridica dei fatti accertati? È da presumere che oggi una parte non piccola della pubblica opinione risponderebbe nel secondo senso dell’alternativa. E non soltanto perché l’avvicinamento a una maggiore verità fattuale è comprensibilmente in considerazione della circostanza che trattasi di un obiettivo in sé meritevole di essere in ogni caso perseguito.
 Una ulteriore ragione va ravvisata nel fatto che per il grosso pubblico le questioni strettamente giuridiche, anche quando sono in gioco problemi di responsabilità penale, non sono percepite come aspetti di rilevanza cruciale. Se ne ha riprova prendendo atto che la maggior parte delle persone e persino delle persone di cultura, ignora quasi del tutto anche le categorie elementari del diritto e le modalità del suo concreto funzionamento operativo. Purtroppo sono sempre diffusi i casi di una sistematica traslazione negli assunti accusatori del P.M. di mere asserzioni vacue proposte nelle “narrazioni” della Polizia Giudiziaria e come tali sguarnite di ogni minima verifica e conseguente validazione di natura giudiziaria. Una illuminante conferma delle nostre modeste riflessioni ci viene autorevolmente incontro da un articolo (Corriere della Sera del 28 Agosto 2015) di Sabino Cassese “Qualcosa si muove nella giustizia. Le riforme avviate nel giugno 2014, articolate in dodici punti, dopo una pubblica consultazione, stanno dando qualche magro frutto: calo del processo civile, tempi più brevi dei processi. Ma la china da risalire è erta. Il contesto è difficile. La qualità delle leggi è pessima (ma nessuno se ne dà carico). Gli avvocati troppi (ma continuano ad aumentare). Il Consiglio Superiore della Magistratura dominato da gruppuscoli denominati correnti (ma non c’è un accordo per uscirne). La Cassazione intasata da un numero abnorme di ricorsi (ma le proposte di soluzione sono troppo timide).
Una ulteriore ragione va ravvisata nel fatto che per il grosso pubblico le questioni strettamente giuridiche, anche quando sono in gioco problemi di responsabilità penale, non sono percepite come aspetti di rilevanza cruciale. Se ne ha riprova prendendo atto che la maggior parte delle persone e persino delle persone di cultura, ignora quasi del tutto anche le categorie elementari del diritto e le modalità del suo concreto funzionamento operativo. Purtroppo sono sempre diffusi i casi di una sistematica traslazione negli assunti accusatori del P.M. di mere asserzioni vacue proposte nelle “narrazioni” della Polizia Giudiziaria e come tali sguarnite di ogni minima verifica e conseguente validazione di natura giudiziaria. Una illuminante conferma delle nostre modeste riflessioni ci viene autorevolmente incontro da un articolo (Corriere della Sera del 28 Agosto 2015) di Sabino Cassese “Qualcosa si muove nella giustizia. Le riforme avviate nel giugno 2014, articolate in dodici punti, dopo una pubblica consultazione, stanno dando qualche magro frutto: calo del processo civile, tempi più brevi dei processi. Ma la china da risalire è erta. Il contesto è difficile. La qualità delle leggi è pessima (ma nessuno se ne dà carico). Gli avvocati troppi (ma continuano ad aumentare). Il Consiglio Superiore della Magistratura dominato da gruppuscoli denominati correnti (ma non c’è un accordo per uscirne). La Cassazione intasata da un numero abnorme di ricorsi (ma le proposte di soluzione sono troppo timide).
I magistrati troppo leggeri nel limitare la libertà personale. L’ermeneutica giudiziaria ormai dominante spesso è mortificata in sterile richiamo agli statuti normativi delle fattispecie astratte, in tautologiche replicazioni, nell’assunto accusatorio, di asserzioni vacue compensate da un diffuso vizio di esprimere giudizi moralistici che normalmente abbondano negli atti della Polizia giudiziaria, trasposti tout court negli atti giudiziari (la Scuola della Magistratura non dovrebbe fare qualcosa per insegnare che la detenzione cautelare, senza processo, va usata in casi estremi?). Troppe le carriere politiche di magistrati in carica e troppe le loro esternazioni (mentre il Consiglio Superiore della Magistratura sta a guardare). Eccessiva la tendenza di procure e corti a dettare l’agenda della politica e a stabilire i criteri della politica industriale, quasi fossero la coscienza del Paese ed il governo della politica economica (perché il Consiglio non fissa le linee guida non vincolanti, come fa negli Stati Uniti il Dipartimento di Giustizia e perché la Scuola di Magistratura non promuove il ricorso all’analisi economica del diritto?). Palese l’inadeguatezza – con l’eccezione di alcune importanti Procure – del contrasto della criminalità organizzata. La criminalità organizzata si è diffusa in vaste aree del territorio nazionale (non varrebbe la pena di fare una analisi sulla preparazione di chi dirige le investigazioni, comprese le forze di polizia?).
 Sproporzionato il posto che il sistema giudiziario è venuto ad occupare nella vita civile, se rapportato al suo fallimento come erogatore del fondamentale servizio della giustizia (qui occorrerebbe una analisi distaccata ed imparziale, alla quale tutti possano partecipare, promossa dal Parlamento). Al fondo, la crisi della giustizia in Italia non sta tanto nell’enorme numero di cause non decise e nei tempi dei processi, ma nel fatto che tutto ciò ha prodotto una vera e propria fuga dalla giustizia, a causa della sfiducia dei suoi tempi. Non vengono da ultime, in questo quadro, le proposte, recentemente ribadite relative ad intercettazioni, carcerazione preventiva e separazione delle carriere. Prima ancora della loro divulgazione, è l’uso a volte eccessivo delle intercettazioni (specialmente di quelle indirette) come mezzo di prova che andrebbe disciplinato ricordando che, secondo la Costituzione, la segretezza delle comunicazioni è inviolabile. La carcerazione preventiva è stata talvolta usata come mezzo di pressione, per ottenere ammissioni di colpa, anche qui mostrando le debolezze investigative nella raccolta documentale di prove (talvolta anche in epoca anteriore alla stessa acquisizione della notitia criminis). Per quanto la sua importanza sia diminuita dopo la distinzione funzionale, la separazione delle carriere, ambedue con indipendenza garantita, è dettata molto semplicemente dal fatto che accusa e giudizio sono mestieri diversi, che richiedono preparazione e professionalità differenti. Il Governo italiano ha finora avuto giudizi molto negativi dalla Corte di Strasburgo e apprezzamenti sia dai commissari europei per le iniziative intraprese nel campo della giustizia, sia dal Consiglio d’Europa per la produttività dei giudici. Ma il tempo passa e risultati più consistenti sono attesi, non solo dai cittadini, ma anche dall’Unione Europea e dal Consiglio d’Europa. Non dimentichiamo che uno dei punti della decisione dell’Eurosummit del luglio scorso relativa alla Grecia, presa con la collaborazione dell’Italia, ha riguardato l’accelerazione delle procedure giudiziarie e la riduzione dei costi della giustizia.”
Sproporzionato il posto che il sistema giudiziario è venuto ad occupare nella vita civile, se rapportato al suo fallimento come erogatore del fondamentale servizio della giustizia (qui occorrerebbe una analisi distaccata ed imparziale, alla quale tutti possano partecipare, promossa dal Parlamento). Al fondo, la crisi della giustizia in Italia non sta tanto nell’enorme numero di cause non decise e nei tempi dei processi, ma nel fatto che tutto ciò ha prodotto una vera e propria fuga dalla giustizia, a causa della sfiducia dei suoi tempi. Non vengono da ultime, in questo quadro, le proposte, recentemente ribadite relative ad intercettazioni, carcerazione preventiva e separazione delle carriere. Prima ancora della loro divulgazione, è l’uso a volte eccessivo delle intercettazioni (specialmente di quelle indirette) come mezzo di prova che andrebbe disciplinato ricordando che, secondo la Costituzione, la segretezza delle comunicazioni è inviolabile. La carcerazione preventiva è stata talvolta usata come mezzo di pressione, per ottenere ammissioni di colpa, anche qui mostrando le debolezze investigative nella raccolta documentale di prove (talvolta anche in epoca anteriore alla stessa acquisizione della notitia criminis). Per quanto la sua importanza sia diminuita dopo la distinzione funzionale, la separazione delle carriere, ambedue con indipendenza garantita, è dettata molto semplicemente dal fatto che accusa e giudizio sono mestieri diversi, che richiedono preparazione e professionalità differenti. Il Governo italiano ha finora avuto giudizi molto negativi dalla Corte di Strasburgo e apprezzamenti sia dai commissari europei per le iniziative intraprese nel campo della giustizia, sia dal Consiglio d’Europa per la produttività dei giudici. Ma il tempo passa e risultati più consistenti sono attesi, non solo dai cittadini, ma anche dall’Unione Europea e dal Consiglio d’Europa. Non dimentichiamo che uno dei punti della decisione dell’Eurosummit del luglio scorso relativa alla Grecia, presa con la collaborazione dell’Italia, ha riguardato l’accelerazione delle procedure giudiziarie e la riduzione dei costi della giustizia.”
Una riflessione conclusiva …
 L’articolo di Sabino Cassese è la sintesi perfetta e condivisibile sullo stato della giustizia in Italia ed una indicazione puntuale della strada che occorre intraprendere per migliorare le condizioni. Il paradosso di una giustizia che è al tempo stesso al massimo della sua inefficienza e al massimo della sua invadenza è denuncia che dovrebbe comportare riflessioni pertinenti e soluzioni adeguate.Allo stesso modo non possono essere dimenticati altri fattori di inefficienza che pure Sabino Cassese prende in esame: dalla inadeguatezza delle indagini, all’utilizzazione sproposita dello strumento intercettativo, dal numero dei processi e dei ricorsi, alla professionalità di tutti gli attori del processo. Ma il ritardo della riforma della giustizia è determinato nel nostro paese anche da luoghi comuni, da timori e da tabù inconfessati, da incrostazioni ideologiche e dall’errato convincimento che alcune riforme possano essere interpretate come un atto di belligeranza nei confronti della magistratura cui da tempo la politica ha delegato funzioni improprie, pensando magari che ciò avrebbe garantito un vivere più quieto. Secondo questo luogo comune la giustizia è dei magistrati ed ogni riforma che la voglia restituire ai cittadini è un atto eversivo. Non è la mitezza delle pene ad incrementare i delitti, ma la altissima probabilità di non essere scoperti. Non è la durezza delle pene detentive ma la diffusa applicazione delle misure alternative ad incrementare la sicurezza dei cittadini. E naturalmente a questo dibattito culturale che si colloca al centro in maniera seria la politica giudiziaria devono partecipare tutti senza timidezze e senza la preoccupazione di essere etichettati come contigui alla criminalità o alla corruzione, laddove si auspichino interventi sulla disciplina delle intercettazioni o si sottolinei che la custodia cautelare debba essere utilizzata come estrema ratio; o ancora essere apostrofati come nemici dell’autonomia e dell’indipendenza della magistratura se si afferma l’ineludibilità della separazione delle carriere, come fisiologica attuazione dell’articolo 11 della Costituzione e della necessaria terzietà del giudice. Tale inevitabile riforma, come acutamente sottolinea il professor Cassese, è anche determinata dal semplice fatto “che accusa e giudizio sono mestieri diversi che richiedono preparazione e professionalità differenti”.
L’articolo di Sabino Cassese è la sintesi perfetta e condivisibile sullo stato della giustizia in Italia ed una indicazione puntuale della strada che occorre intraprendere per migliorare le condizioni. Il paradosso di una giustizia che è al tempo stesso al massimo della sua inefficienza e al massimo della sua invadenza è denuncia che dovrebbe comportare riflessioni pertinenti e soluzioni adeguate.Allo stesso modo non possono essere dimenticati altri fattori di inefficienza che pure Sabino Cassese prende in esame: dalla inadeguatezza delle indagini, all’utilizzazione sproposita dello strumento intercettativo, dal numero dei processi e dei ricorsi, alla professionalità di tutti gli attori del processo. Ma il ritardo della riforma della giustizia è determinato nel nostro paese anche da luoghi comuni, da timori e da tabù inconfessati, da incrostazioni ideologiche e dall’errato convincimento che alcune riforme possano essere interpretate come un atto di belligeranza nei confronti della magistratura cui da tempo la politica ha delegato funzioni improprie, pensando magari che ciò avrebbe garantito un vivere più quieto. Secondo questo luogo comune la giustizia è dei magistrati ed ogni riforma che la voglia restituire ai cittadini è un atto eversivo. Non è la mitezza delle pene ad incrementare i delitti, ma la altissima probabilità di non essere scoperti. Non è la durezza delle pene detentive ma la diffusa applicazione delle misure alternative ad incrementare la sicurezza dei cittadini. E naturalmente a questo dibattito culturale che si colloca al centro in maniera seria la politica giudiziaria devono partecipare tutti senza timidezze e senza la preoccupazione di essere etichettati come contigui alla criminalità o alla corruzione, laddove si auspichino interventi sulla disciplina delle intercettazioni o si sottolinei che la custodia cautelare debba essere utilizzata come estrema ratio; o ancora essere apostrofati come nemici dell’autonomia e dell’indipendenza della magistratura se si afferma l’ineludibilità della separazione delle carriere, come fisiologica attuazione dell’articolo 11 della Costituzione e della necessaria terzietà del giudice. Tale inevitabile riforma, come acutamente sottolinea il professor Cassese, è anche determinata dal semplice fatto “che accusa e giudizio sono mestieri diversi che richiedono preparazione e professionalità differenti”.
Giuseppe Tuccio